Sul tema dei lavoratori digitali (platform worker) riportiamo questo articolo di Mauro De Agostini dal n. 6/marzo 2024 di “Collegamenti per l’organizzazione diretta di classe”
 “Prima di internet, sarebbe stato difficile trovare qualcuno e farlo sedere per dieci minuti a lavorare per te, per poi licenziarlo passati quei dieci minuti. Ma con la tecnologia, in realtà, puoi davvero trovarlo, pagarlo una miseria e poi sbarazzartene quando non ti serve più” (1) questa frase dell’imprenditore americano Lukas Biewald descrive alla perfezione la nuova realtà creata dal capitalismo delle piattaforme.
“Prima di internet, sarebbe stato difficile trovare qualcuno e farlo sedere per dieci minuti a lavorare per te, per poi licenziarlo passati quei dieci minuti. Ma con la tecnologia, in realtà, puoi davvero trovarlo, pagarlo una miseria e poi sbarazzartene quando non ti serve più” (1) questa frase dell’imprenditore americano Lukas Biewald descrive alla perfezione la nuova realtà creata dal capitalismo delle piattaforme.
Una situazione tutt’altro che marginale visto che (secondo stime ufficiali) attualmente risultano attive nella sola Unione europea circa 500 piattaforme digitali che nel 2022 impiegavano almeno 28 milioni di lavoratrici/ori, destinate a diventare 43 milioni entro il 2025, un nuovo proletariato digitale privo di ogni tutela. (2)
Piattaforme “web-based” e “location-based”
Alcune piattaforme, dette “web-based”, operano esclusivamente online arruolando persone (magari in un altro continente) per ottenere prestazioni come traduzioni, lezioni, consulenze, servizi di call center o di chat, oppure per svolgere microlavori come trascrivere una registrazione audio, riconoscere una immagine, risolvere un captcha, leggere uno scontrino. In questi casi ogni singola prestazione fa storia a sé ed è pagata separatamente, non esiste alcuna continuità nel rapporto di lavoro, dirigenti, lavoratori e clienti non si incontrano mai fisicamente tra loro. In tutti questi casi si parla di “crowdwork”, letteralmente “lavoro nella folla”, perché si offre il proprio lavoro in rete a una massa potenzialmente infinita di clienti che poi ti “scelgono”, magari per quell’unica micro-prestazione.
 Altre piattaforme, dette “location-based” offrono servizi sul territorio. Questo è il mondo più familiare dei “rider” che ci portano il cibo a domicilio, dei “driver” di Uber che fungono da tassisti, degli “shopper” che portano la spesa a casa ecc. ecc. Queste piattaforme si avvalgono di lavoratori che operano in un’area geografica delimitata, entrando fisicamente in contatto con i clienti (e potenzialmente tra di loro).
Altre piattaforme, dette “location-based” offrono servizi sul territorio. Questo è il mondo più familiare dei “rider” che ci portano il cibo a domicilio, dei “driver” di Uber che fungono da tassisti, degli “shopper” che portano la spesa a casa ecc. ecc. Queste piattaforme si avvalgono di lavoratori che operano in un’area geografica delimitata, entrando fisicamente in contatto con i clienti (e potenzialmente tra di loro).
I lavoratori (web o location-based), sono considerati normalmente come lavoratori autonomi pagati a prestazione, vengono assunti, diretti, valutati e licenziati da apposite app, sulla base di algoritmi che appaiono imperscrutabili.
Nell’Unione europea, secondo la ricerca sopra citata, sarebbero i dipendenti delle piattaforme “location based” ad essere attualmente la stragrande maggioranza, operando nei seguenti settori:
Taxi 39 % (Uber, ecc.)
Delivery 24 % (consegne a domicilio, sono i vari rider, shopper ecc.)
Casa 19 % (pulizie, riparazioni…)
Servizi professionali 7 % (contabilità…)
Servizi alla persona 6 % (babysitter, assistenza sanitaria)
I dipendenti delle piattaforme “web based” sarebbero invece un modesto 5 % del totale, suddivisi in
Freelance 3 % (graphic design, photoediting)
Micro tasks 2 % (classificare oggetti, taggare, sono i famosi “turchi meccanici” di cui parleremo in seguito). Una percentuale probabilmente sottostimata se consideriamo altri dati che via via esamineremo.
Per quanto riguarda la situazione italiana disponiamo di uno studio dell’INAPP pubblicato nel gennaio 2022(3) Nel 2020/21 potevano essere classificati come lavoratori digitali 570.000 persone, così suddivisi:
36,2 % consegna pasti a domicilio (i rider),
14% consegna prodotti o pacchi,
4,7% autisti (tipo Uber),
9,2 % lavori domestici,
34,9% attività online,
1% altre attività.
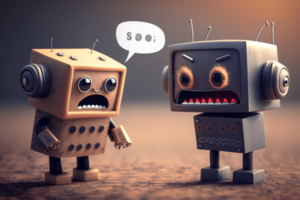 Dal confronto tra le due statistiche emergono sostanziose differenze (dovute sicuramente anche a diversi sistemi di classificazione): risulta più contenuto in Italia il ruolo degli autisti (solo il 4,7 % contro il 39 % europeo), frutto delle notevoli resistenze delle organizzazioni dei taxisti nostrani, mentre più rilevante in percentuale è la consegna a domicilio di pasti (36,2 %) e pacchi e prodotti vari (14 %) contro il 24 % complessivo UE. Colpisce il 34,9 % che in Italia svolgerebbe non meglio precisate “attività online” contro il risicato 5 % a livello europeo.
Dal confronto tra le due statistiche emergono sostanziose differenze (dovute sicuramente anche a diversi sistemi di classificazione): risulta più contenuto in Italia il ruolo degli autisti (solo il 4,7 % contro il 39 % europeo), frutto delle notevoli resistenze delle organizzazioni dei taxisti nostrani, mentre più rilevante in percentuale è la consegna a domicilio di pasti (36,2 %) e pacchi e prodotti vari (14 %) contro il 24 % complessivo UE. Colpisce il 34,9 % che in Italia svolgerebbe non meglio precisate “attività online” contro il risicato 5 % a livello europeo.
Secondo lo studio dell’INAPP i lavoratori digitali in Italia sono per tre quarti maschi, con livelli discreti di istruzione, il 70% di loro ha tra i 30 e i 49 anni, nel 48,1 % dei casi questa è l’attività lavorativa principale, mentre per un altro 24,4 % risulta comunque una fonte di sostegno importante, solo l’11% ha un contratto di lavoro dipendente. In molti casi si può parlare di “caporalato digitale”, con lavoratori “schiavi dell’algoritmo” che decide del loro futuro in base alle prestazioni o ai giudizi dei clienti. Nel complesso “si tratta di un lavoro povero, fragile […] una nuova precarietà digitale”.
Che tutte queste cifre vadano prese con le pinze è dimostrato dal fatto che, secondo stime della fondazione Debenedetti risalenti al 2018, già a quell’epoca le/i platform worker italiane/i si aggiravano sui 700.000-1 milione. Di questi 150.000 avevano nel lavoro digitale la loro unica fonte di reddito. Il fatto che in molti casi le statistiche si basino su dati auto-certificati dalle piattaforme medesime induce ulteriormente alla prudenza.(4)
Comunque uno studio dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) risalente al l 2018 (5) sembra confermare per l’essenziale i dati elaborati dall’INAPP: a livello mondiale i platform worker risultavano essere per due terzi maschi, con un discreto livello di istruzione, un’età media di 33,2 anni (28 nei paesi in via di sviluppo), per il 32 % del campione il lavoro digitale era la principale fonte di reddito.
In precedenti interventi su “Collegamenti” (n. 3 e n. 5) ci siamo occupati ampiamente dei rider e in generale dei lavoratori digitali “location-based”, qui cercheremo invece di fare il punto sulla situazione di chi lavora esclusivamente online.
I “turchi meccanici”
 Se analizziamo il mondo variegato delle lavoratrici/ori “web-based” troviamo prestazioni altamente specializzate come consulenze, traduzioni, grafica, creazione di software, videogiochi ecc. ma anche micro-lavori consistenti nello trascrivere una registrazione audio, riconoscere una immagine, risolvere un captcha, leggere uno scontrino… Questi ultimi sono i cosiddetti “turchi meccanici” che, sottopagati a cottimo, “addestrano” i computer a replicare comportamenti “umani”.
Se analizziamo il mondo variegato delle lavoratrici/ori “web-based” troviamo prestazioni altamente specializzate come consulenze, traduzioni, grafica, creazione di software, videogiochi ecc. ma anche micro-lavori consistenti nello trascrivere una registrazione audio, riconoscere una immagine, risolvere un captcha, leggere uno scontrino… Questi ultimi sono i cosiddetti “turchi meccanici” che, sottopagati a cottimo, “addestrano” i computer a replicare comportamenti “umani”.
“Operai digitali, delocalizzati per lo più tra India, Bangladesh e Nepal, vengono ingaggiati per realizzare davanti a un computer o allo schermo di uno smartphone micromansioni pagate anche un centesimo di dollaro per ogni “task”. Sono i lavoratori umani invisibili che alimentano e “allenano” le intelligenze artificiali, le app e gli assistenti virtuali di cui ci serviamo ogni giorno.” (6)
La dispersione geografica dei lavoratori risulta estremamente vantaggiosa per le piattaforme: consente di raccogliere una mole potenzialmente infinita di informazioni (es. nel riconoscimento di volti o case in contesti diversi), consente, grazie ai diversi fusi orari, di offrire prestazioni 24 ore al giorno, utilizza personale estremamente flessibile (assunto ogni volta per quell’unica prestazione) e difficilmente sindacalizzabile. L’organizzazione del lavoro riprende modelli ampiamente sperimentati come la divisione del lavoro in parti semplici e ripetitive, il lavoro a domicilio, il pagamento a cottimo. (7)
Il termine “turchi meccanici” o “turker”, rimanda a una celebre truffa del 1700. Wolfgang von Kempelen costruì un automa con sembianze umane, vestito come un turco, che era capace di giocare a scacchi tenendo testa anche a grandi campioni. Solo in seguito si scoprì la frode. All’interno della “macchina” si nascondeva un essere umano che ne guidava i movimenti.
Il nome è stato introdotto dall’ineffabile Jeff Bezos nel lanciare, nel 2005, la piattaforma Amazon Mechanical Turk (AMT) con un chiaro significato: dietro ogni “macchina”, che sia l’Intelligenza artificiale (AI)(8), Alexa, Cortana, o il robot aspirapolvere che pulisce il pavimento c’è un trucco: una miriade di esseri umani che l’hanno addestrata e continuano ad addestrarla a svolgere ogni singolo compito.
 Come funziona la piattaforma Amazon Mechanical Turk ? un committente (“requester”) offre dei micro-lavori ciascuno dei quali viene chiamato HIT (Human Intelligence Task). Per lo svolgimento di ciascuno di questi compiti viene offerto un modestissimo compenso. I lavoratori (“provider” o più semplicemente “turker”) scelgono i compiti che preferiscono, li svolgono e ricevono il compenso. Il committente può accettare o meno i “turker” che si offrono, selezionandoli sulla base di determinate caratteristiche, e – quel che è peggio – può rifiutare il lavoro svolto considerandolo fatto male. Questa decisione (praticamente insindacabile) costituisce un doppio danno per il “turker”, oltre ad aver lavorato per niente vede peggiorare il proprio “ranking” con conseguenti ricadute sulle commesse future. Amazon incassa una commissione (20-40 %) su ogni microlavoro svolto.
Come funziona la piattaforma Amazon Mechanical Turk ? un committente (“requester”) offre dei micro-lavori ciascuno dei quali viene chiamato HIT (Human Intelligence Task). Per lo svolgimento di ciascuno di questi compiti viene offerto un modestissimo compenso. I lavoratori (“provider” o più semplicemente “turker”) scelgono i compiti che preferiscono, li svolgono e ricevono il compenso. Il committente può accettare o meno i “turker” che si offrono, selezionandoli sulla base di determinate caratteristiche, e – quel che è peggio – può rifiutare il lavoro svolto considerandolo fatto male. Questa decisione (praticamente insindacabile) costituisce un doppio danno per il “turker”, oltre ad aver lavorato per niente vede peggiorare il proprio “ranking” con conseguenti ricadute sulle commesse future. Amazon incassa una commissione (20-40 %) su ogni microlavoro svolto.
 Se AMT supera attualmente i 500.000 utenti, si calcola che, a livello mondiale, i “turker” siano almeno 100 milioni.(9) I compensi, come abbiamo visto, sono modestissimi tuttavia possono risultare appetibili in molti paesi in via di sviluppo. Dall’indagine dell’ILO (2018) già citata emergeva che il 22 % dei platform worker latino-americani e il 9 % dei lavoratori indiani di AMT riteneva preferibile lavorare per una piattaforma digitale Perché “la remunerazione è migliore di quella di altri lavori disponibili”. (10) Una recente ricerca sul micro-lavoro digitale in Brasile (2023) evidenzia come nel paese operino oltre 50 piattaforme e il compenso medio sia di solo 1,8 dollari all’ora (per un compenso mensile di 112 dollari). Resta confermata la giovane età e l’alto livello d’istruzione della maggior parte delle persone intervistate. In controtendenza ai dati mondiali 3 microworker su 5 sono donne. Le donne sono anche le più ricattabili perché risultano in gran parte disoccupate.(11)
Se AMT supera attualmente i 500.000 utenti, si calcola che, a livello mondiale, i “turker” siano almeno 100 milioni.(9) I compensi, come abbiamo visto, sono modestissimi tuttavia possono risultare appetibili in molti paesi in via di sviluppo. Dall’indagine dell’ILO (2018) già citata emergeva che il 22 % dei platform worker latino-americani e il 9 % dei lavoratori indiani di AMT riteneva preferibile lavorare per una piattaforma digitale Perché “la remunerazione è migliore di quella di altri lavori disponibili”. (10) Una recente ricerca sul micro-lavoro digitale in Brasile (2023) evidenzia come nel paese operino oltre 50 piattaforme e il compenso medio sia di solo 1,8 dollari all’ora (per un compenso mensile di 112 dollari). Resta confermata la giovane età e l’alto livello d’istruzione della maggior parte delle persone intervistate. In controtendenza ai dati mondiali 3 microworker su 5 sono donne. Le donne sono anche le più ricattabili perché risultano in gran parte disoccupate.(11)
Il “body rental”
Svolgere online lavori altamente qualificati non comporta necessariamente migliori condizioni coontrattuali rispetto ai “turker”. Una pratica molto diffusa nel settore delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT) italiano è quella del cosiddetto “body rental”(letteralmente “affitto del corpo”), un vero e proprio caporalato digitale, in cui – come denuncia la Tech Workers Coalition Italia – “il lavoratore viene assunto da un’azienda che svolge un ruolo di intermediazione comparabile a quello di un’agenzia interinale non a norma di legge, “prestando” il lavoratore ad aziende committenti per dei progetti specifici a breve termine. Così, il lavoratore si trova in una situazione di precarietà in cui è esposto costantemente non solo alla possibilità di licenziamento, ma anche a ritmi di lavoro insostenibili, che accelerano lo stress e il burnout.” (12) le aziende sfruttano gli informatici più giovani e inesperti, spesso reclutati quando sono ancora all’università e li inseriscono in un vorticoso giro di consulenze. Il risultato è che il lavoratore viene sottopagato, passando continuamente da un lavoro all’altro non ha la possibilità di crescere professionalmente e anche la qualità del software prodotto ne risente.
Tentativi di resistenza e di organizzazione
Il lavoro digitale appare come l’ultima frontiera dello sfruttamento: manodopera dispersa (spesso nei cinque continenti) micro-compiti pagati a cottimo, lavoratori usa e getta, difficoltà di sindacalizzarsi…. Tuttavia qualche tentativo di resistenza c’è (anche se, almeno per il lavoro “web-based”, siamo ancora lontani da una ipotesi di organizzazione di classe).
Il truffatore truffato
Segnaliamo prima di tutto una forma di resistenza spontanea allo sfruttamento da parte dei turker che sembra attualizzare il vecchio detto: “a paga di merda lavoro di merda”. Secondo uno studio svolto da ricercatori della Scuola politecnica federale di Losanna (EPFL): tra il 33% e il 46% delle lavoratrici/ori di Amazon Mechanical Turk, potrebbe aver “barato” nello svolgimento dei micro-compiti assegnati, utilizzando strumenti come ChatGPT per portarli a termine. Notizia decisamente inquietante per lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale dato che, se il funzionamento dell’AI viene controllato utilizzando la stessa AI, è chiaro che i risultati che ne derivano saranno del tutto inaffidabili! (13)
Turkopticon
 Uno dei problemi più sentiti dalle/dai turker è sicuramente quello dell’asimmetria valutativa tra lavoratori e datori di lavoro, per ovviare a questo problema nel 2008 è stata creata da Lilly Irani e Six Silberman (all’epoca studenti) il sito Turkopticon(14) che consente ai turker di recensire i committenti permettendo così di individuare i numerosi committenti disonesti (quelli che si rifiutano di pagare il lavoro svolto dichiarandolo arbitrariamente malfatto), farli sprofondare nel “ranking” e consentire quindi a lavoratrici/ori di tenersene alla larga.
Uno dei problemi più sentiti dalle/dai turker è sicuramente quello dell’asimmetria valutativa tra lavoratori e datori di lavoro, per ovviare a questo problema nel 2008 è stata creata da Lilly Irani e Six Silberman (all’epoca studenti) il sito Turkopticon(14) che consente ai turker di recensire i committenti permettendo così di individuare i numerosi committenti disonesti (quelli che si rifiutano di pagare il lavoro svolto dichiarandolo arbitrariamente malfatto), farli sprofondare nel “ranking” e consentire quindi a lavoratrici/ori di tenersene alla larga.
È importante osservare che Turkopticon nasce in un’ottica di “cogestione”, non viene cioè messo minimamente in discussione il meccanismo della piattaforma (né tanto meno i suoi lauti profitti) ma ci si propone di migliorarlo, collaborando con AMT. Viene quindi accettato il principio che i turker sono lavoratori autonomi pagati a cottimo. L’obiettivo del sito è quindi quello di garantire la massima trasparenza reciproca tra lavoratori e datori di lavoro. Nel tempo il sito ha subito diverse evoluzioni ed oggi offre, tra l’altro, una “pagella” analitica di ogni committente (15) che indica, insieme a una valutazione globale, la paga oraria media offerta, la media di lavori rifiutati, il tempo di approvazione del lavoro, la qualità delle comunicazioni ai lavoratori. Quanto alla retribuzione viene incasellata in tre fasce: rossa se è inferiore al minimo salariale federale USA (7,25 dollari), arancione se è intermedia, verde se è superiore a 10 dollari all’ora (superiore cioè ai vari standard salariali minimi USA).
Ad oggi Turkopticon ha recensito oltre 30.000 datori di lavoro per un totale di oltre 750.000 recensioni. Dopo 15 anni dalla nascita di Turkopticon gli organizzatori devono però ammettere che il problema dei “rifiuti di massa” del lavoro svolto è tutt’altro che risolto e una petizione rivolta ad AMT nell’agosto 2022 per limitare gli effetti dei rifiuti di massa sulla valutazione dei lavoratori non sembra aver prodotto grandi risultati.(16)
Sarebbe tuttavia sbagliato liquidare con sufficienza questa esperienza di organizzazione. Con tutti i suoi evidenti limiti ha consentito di mettere in comunicazione stabilmente centinaia di migliaia di lavoratori digitali, precedentemente isolati, che ora hanno la possibilità di confrontarsi quotidianamente su vari forum e piattaforme.
Coworker (e Unit)
Coworker (17) viene fondata nel 2013 negli Stati Uniti da Jess Kutch e Michelle Miller come piattaforma di petizioni online dedicata ai problemi dei lavoratori non sindacalizzati con l’obiettivo di “impedire ai datori di lavoro di smantellare i diritti del lavoro e dell’occupazione duramente conquistati”, si è via via trasformato in un “hub” che attraverso campagne di opinione ha favorito la sindacalizzazione dei lavoratori in varie realtà.
Tra i successi vantati dalla piattaforma: aver contribuito alla sindacalizzazione dei baristi di Starbucks (partendo da una petizione a favore del diritto di tatuarsi), e dei dipendenti della coop di consumo REI (Recreational Equipment, Inc.), miglioramenti nelle condizioni di lavoro dei dipendenti di Google che “cercavano l’uguaglianza razziale e di genere sul lavoro e protestavano contro il ruolo dell’azienda nella costruzione di armi da guerra e di sorveglianza”, successi durante la pandemia nell’ottenere indennità di rischio, DPI e giorni di malattia per alcune categorie di precari. Rilevanti anche le campagne contro l’uso opaco degli algoritmi per controllare i lavoratori e ridurre i loro compensi e a favore degli autisti di Uber.
Da notare che in molti casi queste campagne hanno ottenuto risultati positivi perché sono riuscite a smascherare davanti all’opinione pubblica il profilo fintamente progressista del datore di lavoro (Starbucks, REI) che nascondeva invece il classico “padrone delle ferriere”. In ogni caso i successi riguardano essenzialmente lavoratori “tradizionali” o digitali “location-based”.
Da segnalare anche la piattaforma Unit, che fornisce consigli pratici su come organizzare un sindacato negli USA.(18)
Tech Workers Coalition
Un più accentuato profilo di classe è evidenziato dalla Tech Workers Coalition (19) nata nel 2014 a San Francisco a seguito di uno sciopero congiunto di programmatori e personale di servizio per far assumere il personale della mensa di Google a tempo indeterminato. L’associazione (anch’essa in contatto con Turkopticon) vanta sedi in diversi paesi del mondo tra cui l’Italia. TWC non si propone come nuovo sindacato ma piuttosto come “facilitatore” di relazioni tra i diversi sindacati, comitati spontanei, ricercatori ecc. che operano sul campo. In Italia appare prevalentemente presente tra tecnici, creativi e data-worker e risulta soprattutto impegnata nella lotta contro il “body rental” e per favorire la sindacalizzazione dei lavoratori.
Sindacati consociativi
 La novità del lavoro digitale ha attratto l’attenzione anche dei sindacati consociativi europei. La tedesca IgMetall, in accordo coi sindacati austriaci e svedesi (e con l’aiuto della fondatrice di Turkopticon Lilly Irani), ha creato la piattaforma Faircrowd (20) con l’intento di intercettare i “platform worker” operanti nei tre paesi. Nel dicembre 2016 una serie di sindacati europei e americani ha sottoscritto la “dichiarazione di Francoforte” richiedendo la definizione di un quadro normativo a tutela dei lavoratori. (21) Nel 2018 la Confederazione europea dei sindacati ha commissionato un ampio report sull’argomento. (22)
La novità del lavoro digitale ha attratto l’attenzione anche dei sindacati consociativi europei. La tedesca IgMetall, in accordo coi sindacati austriaci e svedesi (e con l’aiuto della fondatrice di Turkopticon Lilly Irani), ha creato la piattaforma Faircrowd (20) con l’intento di intercettare i “platform worker” operanti nei tre paesi. Nel dicembre 2016 una serie di sindacati europei e americani ha sottoscritto la “dichiarazione di Francoforte” richiedendo la definizione di un quadro normativo a tutela dei lavoratori. (21) Nel 2018 la Confederazione europea dei sindacati ha commissionato un ampio report sull’argomento. (22)
In Italia appare particolarmente attiva la UIL che ha creato un sito per networkers, svolge opera di consulenza e ha prodotto alcune ricerche sul tema (23), CGIL e CISL cercano di intervenire nel campo rispettivamente attraverso NIDIL e “VIVAce!” che però sono organismi rivolti genericamente ai lavoratori autonomi e/o atipici. Tra gli ultimi arrivi (2020) anche una Smart worker union (24) che pare essere un classico sindacato autonomo. I sindacati di base sembrano invece gravemente in ritardo nell’intervento (certo non facile) in un settore in continua espansione.
Il tormentone della Direttiva europea sul lavoro digitale
Le vicende della Direttiva UE sui lavoratori digitali danno l’impressione di una specie di gioco dell’oca in cui ci si ritrova ogni volta al punto di partenza. Fin dal 2017, sospinta dalle mobilitazioni spontanee dei taxisti di Uber e dei rider e dalle richieste dei sindacati consociativi, la Commissione Europea era stata sollecitata ad elaborare una normativa in merito.
 Solo a dicembre 2021 era stata presentata in pompa magna una proposta di Direttiva, in base a cui i platform worker avrebbero dovuto essere classificati come lavoratori dipendenti (salvo prova contraria da fornirsi da parte del datore di lavoro) se il loro rapporto di lavoro avesse soddisfatto almeno due dei seguenti cinque indicatori:
Solo a dicembre 2021 era stata presentata in pompa magna una proposta di Direttiva, in base a cui i platform worker avrebbero dovuto essere classificati come lavoratori dipendenti (salvo prova contraria da fornirsi da parte del datore di lavoro) se il loro rapporto di lavoro avesse soddisfatto almeno due dei seguenti cinque indicatori:
1-2) la retribuzione e le regole di condotta sono stabilite unilateralmente dall’azienda,
3) la piattaforma supervisiona il lavoro e lo valuta, anche attraverso strumenti elettronici,
4) la piattaforma limita la possibilità di definire l’orario di lavoro e di accettare o rifiutare gli incarichi,
5) la piattaforma limita la possibilità di lavorare per altre aziende.
Inoltre le app utilizzate avrebbero dovuto garantire trasparenza sull’utilizzo degli algoritmi per il monitoraggio e la valutazione del personale.
In base alle stime UE questi nuovi criteri avrebbero consentito di riclassificare come dipendenti circa 5,5 milioni di lavoratori digitali, in particolare tra quelli “location-based” (taxisti, rider ecc.).
Subito è iniziato il lavorio delle aziende per bloccare l’iter legislativo (in particolare con la richiesta che venissero previsti almeno 3 requisiti su 5 per presumere l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente) al contrario sindacati e organismi di base hanno messo in luce come i criteri fossero troppo elastici e potessero essere facilmente elusi dal padronato (si vedano in proposito le critiche dei rider spagnoli sul n. 3 di “Collegamenti”).
A dicembre 2023 (e cioè dopo due anni di tira e molla) si è bloccato tutto per l’opposizione di un nutrito numero di stati membri capeggiato dalla Francia. A febbraio sembrava raggiunto un accordo in base al quale saltavano i cinque parametri, rimaneva la presunzione di lavoratore dipendente in base però alla presenza di molto più vaghi “fatti che indicano il controllo e la direzione, secondo la legge nazionale, i contratti collettivi o la prassi in vigore negli Stati membri e tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia”, rimaneva anche l’obbligo di trasparenza delle app e la proibizione di procedure di licenziamento automatiche (cioè non revisionate da un essere umano). Ma pochi giorni dopo, in sede di Consiglio europeo, si è bloccato di nuovo tutto a causa dell’astensione di Francia, Germania, Grecia ed Estonia, che non ha consentito di raggiungere la prescritta maggioranza qualificata.
E ora ? La norma deve essere nuovamente approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo (con tempi incerti), si parla di una nuova riunione del Consiglio europeo a metà marzo che forse consentirà di partorire l’ennesimo compromesso al ribasso ma l’incombere delle elezioni europee fa prevedere ulteriori slittamenti.
[NOTA REDAZIONALE l’11 marzo, quando questo articolo era già in stampa – il Consiglio europeo ha effettivamente confermato l'”accordo provvisorio” di febbraio. L’iter legislativo prosegue e la sostanza della valutazione politica non cambia]
Tuttavia quando pure la Direttiva venisse varata non sarebbe (a differenza di un Regolamento) immediatamente applicabile negli Stati membri, ma dovrebbe essere tradotta in leggi nazionali, con relativo rinvio di anni e concreti rischi di insabbiamenti e stravolgimenti.
 Rendere farraginoso l’iter legislativo, varare leggi ambigue (quella italiana è un capolavoro da azzeccagarbugli)1, trascinare lavoratrici e lavoratori in estenuanti battaglie giudiziarie sono elementi costitutivi della strategia padronale. Nessun risultato potrà essere ottenuto senza una adeguata organizzazione di classe delle lavoratrici/ori digitali. Se, per quanto riguarda rider ed autisti, abbiamo già assistito ad importanti momenti di mobilitazione, l’organizzazione del proletariato “web-based” costituisce la grande sfida del futuro.
Rendere farraginoso l’iter legislativo, varare leggi ambigue (quella italiana è un capolavoro da azzeccagarbugli)1, trascinare lavoratrici e lavoratori in estenuanti battaglie giudiziarie sono elementi costitutivi della strategia padronale. Nessun risultato potrà essere ottenuto senza una adeguata organizzazione di classe delle lavoratrici/ori digitali. Se, per quanto riguarda rider ed autisti, abbiamo già assistito ad importanti momenti di mobilitazione, l’organizzazione del proletariato “web-based” costituisce la grande sfida del futuro.
NOTE
(1) Antonio Aloisi, Valerio De Stefano, Il tuo capo è un algoritmo. Contro il lavoro disumano, Bari, Laterza, 2020, p. 94. Il presente lavoro costituisce uno sviluppo dei miei precedenti articoli https://umanitanova.org/platform-workers-nuove-frontiere-dello-sfruttamento/ e https://umanitanova.org/intelligenza-artificiale-il-lavoro-nero-dei-turchi-meccanici/
(2) https://www.consilium.europa.eu/it/policies/platform-work-eu/
(3) Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, “Lavoro virtuale nel mondo reale: i dati dell’Indagine Inapp-Plus sui lavoratori delle piattaforme in Italia”, A cura di Francesca Bergamante, Francesca Della Ratta, Massimo De Minicis, Emiliano Mandrone, gennaio 2022, https://www.startmag.it/wp-content/uploads/Policy-brief_lavoratori_piattaforme_Italia.pdf alcune citazioni sono tratte dal comunicato stampa dell’INAP https://www.inapp.org/it/inapp-comunica/sala-stampa/comunicati-stampa/04012022-lavoro-inapp-%E2%80%9Caltro-che-gig-economy-8-lavoratori-su-dieci-delle-piattaforme-%C3%A8-una-fonte-di-sostegno-importante-o-addirittura-essenziale%E2%80%9D
(4) Antonio Aloisi, Valerio De Stefano, Il tuo capo è un algoritmo. Cit., p. 99-100.
(5) Janine Berg, Marianne Furrer, Ellie Harmon, Uma Rani, M. Six Silberman, Digital labour platforms and the future of work . Towards decent work in the online world Report: Digital labour platforms and the future of work: Towards decent work in the online world (ilo.org) , d’ora in poi: ILO (il report è disponibile anche in francese e spagnolo).
(6) Lidia Baratta, Siamo già nell’era del microlavoro (e non è una buona notizia), l’autrice riprende nell’articolo un intervento di Antonio Casilli, https://www.linkiesta.it/2017/06/siamo-gia-nellera-del-microlavoro-e-non-e-una-buona-notizia/
(7) ILO cit., p. 6-7.
(8) Sull’AI si veda il recente Stefano Borroni Barale, L’intelligenza inesistente. Un approccio conviviale all’intelligenza artificiale, Milano, Altraeconomia, 2023.
(9) Lidia Baratta, Siamo già nell’era del microlavoro cit.
(10) ILO cit p. 38-39.
(11) Matheus Viana Braz, Paola Tubaro, Antonio A. Casilli, Microwork in Brazil. Who are the workers behnd artificial intelligence, giugno 2023 https://www.researchgate.net/publication/372156591_Microwork_in_Brazil_Who_are_the_workers_behind_artificial_intelligence
(12) Viola Stefanello, I lavoratori tech si organizzano, ma cosa vogliono? https://www.guerredirete.it/i-lavoratori-tech-si-organizzano-cosa-vogliono/
(16) https://www.coworker.org/petitions/end-the-harm-of-mass-rejections
(17) https://home.coworker.org/
(18) https://guide.unitworkers.com/
(21) http://faircrowd.work/unions-for-crowdworkers/frankfurt-declaration/
(22) https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2018-09/Prassl%20report%20IT1.pdf
(23) https://sindacato-networkers.it/ nel 2019 il sindacato ha anche prodotto un report sui gig workers italiani https://sindacato-networkers.it/2019/09/osservatorio-sulla-gig-economy-in-italia-i-risultati-del-2019/
(24) https://smartworkersunion.it/chi-siamo/
(25) Si vedano gli articoli sui rider nei n. 3 e 5 di “Collegamenti”.


Commenti recenti