Da “Collegamenti per l’organizzazione diretta di classe” n. 9/Primavera 2025 riportiamo questo contributo di Gianni e Nicole. La sezione è completata dalla scheda che gli dedica il “Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social” e dall’articolo “Henri Simon e Collegamenti” di Cosimo
 Gianni : Ho letto i primi testi di Henri nelle traduzioni pubblicate dal bollettino ciclostilato milanese Collegamenti, precursore dell’omonima rivista uscita nel 1977. Si trattava di diverse traduzioni – soprattutto dal francese – volte a far circolare testi che sembravano vicini alle nostre posizioni politiche, pur con alcune differenze, nel clima militante italiano dominato da gruppi leninisti e neoleninisti.
Gianni : Ho letto i primi testi di Henri nelle traduzioni pubblicate dal bollettino ciclostilato milanese Collegamenti, precursore dell’omonima rivista uscita nel 1977. Si trattava di diverse traduzioni – soprattutto dal francese – volte a far circolare testi che sembravano vicini alle nostre posizioni politiche, pur con alcune differenze, nel clima militante italiano dominato da gruppi leninisti e neoleninisti.
Il primo numero di questo bollettino (novembre 1973) conteneva una critica all’idea di autogestione e in particolare all’esperienza jugoslava, tratta da Solidarity e pubblicata da ICO. L’introduzione al testo è anonima, ma vi si riconosce lo stile di Henri.
Vengono in seguito pubblicati: nel numero 3 del bollettino, una parte del punto di vista di Henri sull’ultra-sinistra francese e su ICO, che aveva appena lasciato; nel numero 4, un testo di Henri sull’evoluzione delle classi sociali in Francia e sul suo impatto sulle dinamiche di un gruppo come ICO; nel numero 6, il testo “Il nuovo movimento”, che il collettivo milanese vede come una critica alle proprie concezioni teoriche, ma che ritiene utile per chiarire le differenze.
Abbiamo quindi deplorato l’autoscioglimento di ICO, ma abbiamo accolto con interesse la nascita di Echanges et mouvements. Da parte mia, ho conosciuto un membro del collettivo redazionale durante una sua visita in Italia. Sapevo che Henri era il cuore e l’anima della rivista, ma l’ho incontrato solo dopo esser venuto a Parigi, nel 1985.
Le nostre riviste erano infatti legate da una cultura politica molto simile, ed in particolare dallo stesso riferimento al comunismo dei consigli, e dalla stessa attenzione all’autorganizzazione della classe operaia, in particolare nel mondo della produzione. Ho apprezzato anche l’apertura mentale di Echanges, che presentava molte pubblicazioni libertarie, di estrema sinistra e di ultra-sinistra senza lesinare critiche nei loro confronti.
Detto questo, non mancavano differenze di analisi e persino elementi di disaccordo. Io trovavo lo schema interpretativo di Henri talvolta tagliato con l’accetta, un po’ troppo rigido, come se Henri cercasse nella realtà la conferma del suo schema analitico e non il contrario. Uno schema che si potrebbe sintetizzare come segue: gli operai lottano, i sindacati tradiscono, il capitale ristruttura, il che spinge gli operai a lottare – e il ciclo ricomincia da capo.
Ora, io vedevo in questo schema due problemi irrisolti: 1) nelle lotte del proletariato, come nelle rivendicazioni e nelle azioni del capitale o in quelle dei sindacati, ci sono spesso una serie di faglie che, a mio avviso, l’azione poteva sfruttare per rafforzare e orientare le lotte, cosa a cui Henri negava qualsiasi legittimità, classificando fin dall’inizio qualsiasi forma di intervento militante come una deviazione della volontà della base; 2) questo schema non lasciava spazio alla rottura rivoluzionaria o all’azione volontaria di minoranze agenti, che a mio parere avevano un ruolo da giocare.
Nicole : È stato grazie al piccolo gruppo che si riuniva intorno alla rivista Spartacus, diretta e pubblicata da René Lefeuvre, che sono stata portata a leggere le prime produzioni di Echanges e di Henri. Mi ispiravano sia il rispetto per il suo lavoro di raccolta di informazioni sui conflitti di lavoro – che dava alla lotta di classe un contenuto sensibile e concreto – ma anche, con il passare del tempo, un certo riserbo: queste cronache della lotta secolare tra operai e padroni non aiutavano, a mio avviso, a comprendere il clima di regressione dell’idea rivoluzionaria che stavamo dolorosamente vivendo negli anni Ottanta. La portata della controffensiva capitalista mi sembrava molto sottovalutata, ed è quello che cercai di dire scrivendo una “lettera critica” all’articolo di Henri sull’Inghilterra nel numero 10 di Collegamenti, pubblicata a sua volta nel numero 11, e che suscitò da parte sua una risposta di… 80 pagine, che ovviamente non fu pubblicata – non si attacca impunemente una tale autorità, mi fecero capire i compagni…
A quattro mani :
Dal 1986 cominciammo a nostra volta, a Parigi, a contribuire alla pubblicazione di opuscoli in formato A5 – inizialmente con il titolo Les Cahiers du doute, poi Les Cahiers du Cercle Berneri – che riflettevano i dibattiti di un piccolo gruppo di amici politici, tra cui ex membri di Socialisme ou Barbarie e ICO.
Se confrontiamo le analisi di Henri e le nostre sui principali movimenti di questo periodo, possiamo ancora vedere una base comune, ma le divergenze appaiono più chiaramente, ad esempio sul ruolo dei coordinamenti nati nel 1986. È anche difficile negare che all’interno del “gruppo senza nome”, ultimo erede di questa esperienza (i cui verbali di discussione non sono mai stati pubblicati), ci sia stato ad un certo punto un po’ di rancore nei suoi confronti, a causa del sostegno morale che aveva dato a un’iniziativa poco gloriosa: il processo intentato per iscritto da alcuni compagni, senza una parola di difesa, contro la nostra amica e compagna Rina Saint-James per un presunto furto di lavoro di traduzione – iniziativa che poi Henri giustificò con la banalità (del tutto reale, probabilmente) di tali pratiche nei “nostri ambienti”… Questo episodio spiega la decisione presa per un lungo periodo di mantenere una certa distanza dal piccolo mondo di Echanges.
Le differenze nelle nostre analisi sono diventate evidenti più tardi, quando abbiamo pubblicato, con alcuni altri compagni, i tre numeri de La Question sociale (2004-2006). Erano evidenti, e persino esplicite, quando si trattava dell’esperienza dei collettivi di solidarietà, che abbiamo raccontato in dettaglio dopo aver contribuito in larga misura a farla nascere nell’arco di dieci anni (dal 2001 al 2011). La formazione di questi collettivi per sostenere gli scioperi nei settori della ristorazione e delle pulizie negli alberghi, aggirando così la minaccia di licenziamento che prendeva di mira gli scioperanti, ci sembrava un metodo di lotta adatto a un contesto di crescente precarizzazione del lavoro e di subappalto diffuso. Da parte sua, Henri, rispondendo nel numero 100 di Echanges a una richiesta degli amici tedeschi della rivista Wildcat, ci vedeva solo lotte molto limitate, valorizzate artificialmente da aspiranti al ruolo di avanguardia e dal ricorso all’amplificazione mediatica. Ma è stato così gentile da pubblicare nel numero 102 la nostra risposta dettagliata allo stesso articolo.
Le rivolte del 2005 hanno a loro volta messo in luce forti differenze. È vero che il riferimento comune al movimento operaio non era più pertinente di fronte a un fenomeno del genere. Bisognava trovare altri strumenti analitici.
Ma questo non significava che avessimo litigato con lui. L’esperienza dei primi “summercamps” ci ha fatto conoscere anche la sua accattivante dimensione umana; e, nel gruppo di discussione parigino a cui questa ha dato origine per due anni, abbiamo condiviso una certa divertita visione critica di alcune aberrazioni teoriche prodotte dal piccolo mondo dei “comunizzatori”.
E poi, negli ultimi quindici anni, lo abbiamo finalmente ritrovato attorno al tavolo dove, dal 2007, si svolgono i dibattiti del gruppo “Soubis”, nato in seguito alla pubblicazione dell’antologia Socialisme ou barbarie. È lì che Henri ha ritrovato alcuni degli ex membri di questo gruppo storico, che aveva segnato il suo ingresso in politica e che aveva finito per lasciare nel 1958.
Partecipò poco al dibattito sul movimento dei Gilet Gialli, che occupò il gruppo per più di una riunione. Ma la pubblicazione del suo opuscolo sull’argomento – in cui utilizzava la matematica per dimostrare la mancanza di consistenza e di impatto sulla società di questo fenomeno, analizzando al contempo tutto ciò che denunciava come avanguardista – ci ha mostrato che ciò che ci separava non era solo l’uso di strumenti analitici diversi. Perché ci sono dinamiche che non si possono capire solo leggendo i giornali; bisogna avvicinarcisi, lasciarsi penetrare da esse, per capirne davvero la forza e i limiti. (1).
Gianni : Henri ha dedicato i suoi ultimi anni a mettere in ordine le sue carte e la sua memoria, lasciando diversi volumi di corrispondenza, analisi e ricordi. È un esempio che dovrebbe ispirare molti di noi, se non vogliamo abbandonare le nostre carte alla critica dei topi.
A quattro mani : Speriamo che questo permetta alle giovani generazioni che vorranno interessarsene di cogliere non solo la ricchezza di una vita, ma anche la coerenza e la costanza di un’opera lunga settant’anni, interamente dedicata alle lotte operaie e alla difesa dell’idea dell’attività autonoma dei proletari – l’unico vero terreno, ai suoi occhi, della lotta di classe.
NOTE
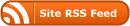
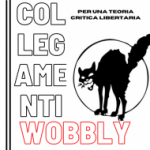
Commenti recenti