Da Collegamenti per l’organizzazione diretta di classe n. 9/Primavera 2025 riportiamo questa intervista a Jean-Arnault Dérens sulla vasta mobilitazione popolare in atto in Serbia (di cui i media mainstream parlano poco e in modo distorto)
Da diversi mesi la Serbia sta vivendo una potente mobilitazione sociale, che si sta gradualmente diffondendo in altri Paesi dei Balcani, ma che i media ignorano. Jean-Arnault Dérens, caporedattore del Courrier des Balkans (1), ne descrive e analizza le caratteristiche in questa versione condensata di un’intervista realizzata il 3 marzo per la trasmissione radio “Vive la sociale” (2).
Per cominciare, può farci una rapida sintesi di queste mobilitazioni?
 La Serbia sta vivendo attualmente il più grande movimento sociale della sua storia recente, o almeno dalla caduta di Milosevic nell’ottobre 2000. È iniziato in modo quasi aneddotico, in reazione al crollo, il 1° novembre, della tettoia esterna della stazione ferroviaria di Novi Sad, la principale città del sud del Paese, che ha causato la morte di quindici persone. Questo disastro è stato subito percepito dalla popolazione locale come un simbolo della corruzione generalizzata delle autorità serbe, poiché la stazione, situata sulla linea ad alta velocità che dovrà collegare Belgrado a Budapest, era stata appena rifatta dalla società cinese che sta costruendo la linea, e quindi c’erano state delle malversazioni nell’appalto. Gli abitanti si sono subito mobilitati per denunciare la corruzione. Dopo le prime manifestazioni a Novi Sad nel mese di novembre, il movimento si è esteso ad alcune università e scuole superiori di Belgrado nelle settimane successive. Le violenze commesse da individui anonimi, senza dubbio sbirri del governo, hanno radicalizzato il movimento, spingendo altri studenti a muoversi, e dall’inizio di dicembre decine di facoltà e istituti superiori erano occupati – oggi sono circa una sessantina.
La Serbia sta vivendo attualmente il più grande movimento sociale della sua storia recente, o almeno dalla caduta di Milosevic nell’ottobre 2000. È iniziato in modo quasi aneddotico, in reazione al crollo, il 1° novembre, della tettoia esterna della stazione ferroviaria di Novi Sad, la principale città del sud del Paese, che ha causato la morte di quindici persone. Questo disastro è stato subito percepito dalla popolazione locale come un simbolo della corruzione generalizzata delle autorità serbe, poiché la stazione, situata sulla linea ad alta velocità che dovrà collegare Belgrado a Budapest, era stata appena rifatta dalla società cinese che sta costruendo la linea, e quindi c’erano state delle malversazioni nell’appalto. Gli abitanti si sono subito mobilitati per denunciare la corruzione. Dopo le prime manifestazioni a Novi Sad nel mese di novembre, il movimento si è esteso ad alcune università e scuole superiori di Belgrado nelle settimane successive. Le violenze commesse da individui anonimi, senza dubbio sbirri del governo, hanno radicalizzato il movimento, spingendo altri studenti a muoversi, e dall’inizio di dicembre decine di facoltà e istituti superiori erano occupati – oggi sono circa una sessantina.
Questo movimento si è costruito a partire da queste facoltà occupate, la cui azione è diretta da plenum studenteschi, con una richiesta molto forte di democrazia diretta e di uguaglianza nella circolazione della parola. Non c’è un portavoce, non c’è un leader, è davvero un movimento che parte e si struttura dal basso, a partire da questi plenum studenteschi presenti in tutte le facoltà occupate. Allo stesso tempo, l’azione simbolica consiste nel riunirsi ogni giorno alle 11,52 per osservare quindici minuti di silenzio, talvolta bloccando strade e incroci in tutta la Serbia. Tutte le categorie sociali si riuniscono nelle principali città. È molto impressionante perché all’improvviso si fà il silenzio, le strade principali sono interrotte e centinaia o migliaia di persone, a seconda del luogo, rimangono immobili in silenzio per quindici minuti.
Poi ci sono state due cose. In primo luogo, per far tenere il movimento sul lungo termine, gli studenti hanno organizzato una serie di azioni e grandi raduni. Il più importante di questi è stato il blocco di 24 ore dell’Autokomanda, il principale snodo stradale per entrare nella capitale, il 25 gennaio. Poi ci sono stati raduni nazionali fuori Belgrado (prima a Novi Sad, poi a Kragujevac, quindi il 1° marzo a Niš, nel sud del Paese, ed il 15 marzo a Belgrado), con l’idea che il movimento si estendesse a tutto il Paese. Questi raduni, che riuniscono decine o migliaia di persone a seconda del luogo, durano molto a lungo – 46 ore a Niš, per esempio, con un intero programma per riempire il tempo. Accanto ai raduni, ci sono le marce, come A Niš dove sono confluite almeno cinque colonne da diverse parti del Paese e quella partita da Belgrado ha percorso 240 km, soprattutto a piedi ma anche in parte in bicicletta.
Ma perché farlo? Per occupare il terreno, per durare a lungo, ma anche, in un contesto di black-out da parte dei media controllati dal regime, per mostrare fisicamente la presenza del movimento nelle piccole città e nei villaggi. E ovunque la gente li ha accolti, spesso con bancarelle di cibo, cucine improvvisate e striscioni come “I contadini nutrono gli studenti che difendono la libertà”. Spesso si sono viste scene sorprendenti, come nei piccoli paesi gli striscioni : “Benvenuti ai liberatori”, un ricordo simbolico della liberazione del 1945.
Oltre agli studenti, si sono mobilitati altri gruppi sociali, come gli insegnanti delle scuole secondarie, gli avvocati, che hanno scioperato per un mese bloccando completamente il sistema giudiziario, ma anche i contadini – e i trattori degli agricoltori sono utili per bloccare le strade ed eventualmente prendere posizione intorno alle facoltà. Quando ci sono stati atti di violenza (non ce ne sono stati da un mese a questa parte), abbiamo visto trattori venire a proteggere i plenum degli studenti con cuori rossi e la scritta “Spread the love”! Si sta vedendo l’inizio di un allargamento ad altre categorie sociali, anche se le cose non sono molto facili.
Niente scioperi?
Sono stati indetti vari scioperi. A gennaio c’è stato uno sciopero generale, quando praticamente tutti i caffè e i negozi hanno chiuso. Uno dei grandi problemi degli scioperi è che la Serbia è un Paese quasi completamente deindustrializzato a causa delle politiche neoliberiste degli ultimi decenni; quindi, a parte il settore pubblico, non ci sono molti posti in cui è possibile scioperare. Tuttavia, è stato lanciato un nuovo appello allo sciopero per il 6 marzo. Nelle secondarie gli insegnanti sono nell’insieme in agitazione, con modalità differenti a seconda dei posti: dalla fine di gennaio sono stati occupati vari istituti medi e licei, mentre altrove si tratta più che altro di uno sciopero a singhiozzo, con lezioni sospese per quindici minuti. In alcune zone rurali, gli insegnanti dicono di appoggiare lo sciopero, ma non si permettono di scioperare, perché è molto difficile per gli alunni raggiungere le loro scuole ora che non c’è più il trasporto scolastico gratuito. Quindi questo movimento ha il sostegno della stragrande maggioranza dei cittadini, se non altro perché tutti hanno un figlio, un vicino di casa, che è uno studente. Quindi tutte le categorie sociali sono toccate molto rapidamente.
Quali sono le ragioni di questo movimento?
Ho già parlato della corruzione, ma una parola sul regime al potere è d’obbligo. Il Presidente Aleksandar Vučić proviene dall’estrema destra nazionalista: è stato Ministro dell’Informazione alla fine del regime di Milosevic, poi nel 2008 ha lasciato il partito nazionalista, il Partito Radicale Serbo di estrema destra (che ha stretti legami con il Front National [francese]), provocando una scissione con l’obiettivo di trasformarlo in un partito conservatore teoricamente europeista e di “centro-destra” (un po’ come l’aggiornamento di Alleanza Nazionale in Italia). Questo nuovo partito, chiamato Partito Progressista Serbo (SNS), è riuscito pochi anni dopo a prendere il potere, Vučić è diventato vice primo ministro nel 2012, primo ministro nel 2014 e presidente della Repubblica nel 2017. Oggi il suo partito, insieme ai suoi piccoli alleati che gli fanno da copertura, ha la maggioranza assoluta nell’Assemblea nazionale e controlla tutti i comuni del Paese, nessuno dei quali sfugge alla sua morsa. Ha una posizione ufficialmente pro-europea, difende l’integrazione della Serbia nell’UE, ma allo stesso tempo mantiene buoni rapporti con la Russia e Putin, ha stretti legami con Victor Orban e una grande ammirazione per Donald Trump – per il quale ha invitato la diaspora serba a votare (una diaspora numerosa, che per di più è concentrata negli Stati strategici della Rust Belt). Si posiziona quindi chiaramente nella riconfigurazione dell’estrema destra europea e mondiale a cui stiamo assistendo oggi. E’ quindi di un partito specialista dell’equilibrismo, ma che ha mantenuto le stesse pratiche e la stessa cultura di potere del Partito Radicale Serbo da cui è nato: monopolio dei media (per quanto riguarda i media, la Serbia scende di anno in anno in tutte le classifiche sulla libertà di stampa), stretto controllo sul sistema giudiziario, ma anche controllo sull’intera vita sociale. Praticamente, se non avete la tessera del partito, avrete difficoltà ad iscrivere i vostri figli all’università, a trovare il lavoro che desiderate, e se avviate una piccola attività, un commercio, bar o altro, avrete automaticamente un controllo fiscale. Naturalmente c’è anche l’acquisto di voti e anche brogli (durante le ultime elezioni locali a Belgrado, si sono visti autobus provenienti dalla Bosnia per assicurare la sua vittoria nella capitale, ma di solito è un po’ più sottile di così). La popolazione si sottomette a questo controllo sociale per necessità, ma lo rigetta massicciamente.
Le rivendicazioni degli studenti sono estremamente intelligenti e di una semplicità biblica: chiedono che tutti i documenti relativi alla gara d’appalto e alla costruzione della stazione di Novi Sad siano resi pubblici. Una richiesta semplice, ma impossibile da soddisfare per le autorità, perché significherebbe rivelare come la catena della corruzione arrivi fino ai livelli più alti dello Stato, fino al Presidente stesso. Per di più, gli studenti si sono sempre rifiutati di incontrare il presidente (“non c’è nulla da discutere, vogliamo solo che vengano rispettate la legge e la Costituzione”) e hanno persino scelto di non nominarlo, perché Vučić ama presentarsi come un eroe sacrificale che difende il Paese dai nemici interni ed esterni. E dicono di opporsi non al “regime”, per non personalizzare la loro lotta, ma al “sistema”, che si riferisce a qualcosa di più ampio: questa forma di privatizzazione dello Stato, questo insieme di relazioni sistemiche di corruzione tra istituzioni, partiti politici, circoli economici e ambienti criminali che ha caratterizzato la Serbia fin dall’inizio della transizione, nei primi anni Duemila – e questo indipendentemente dal partito al potere (quando l’opposizione liberale era al potere, la realtà in termini di corruzione non era molto diversa). Quello che gli studenti chiedono è quindi una sorta di reset generalizzato dell’intero funzionamento politico e sociale del Paese.
Se il movimento si rifiuta di avere dei rappresentanti, è sia per ragioni pratiche (per evitare che vengano attaccati dal regime, o magari comprati), ma anche per esigenze molto radicali di democrazia diretta. Gli studenti fanno sapere ovunque che non hanno leader – l’ho sentito dire sia alla conferenza stampa di Parigi, sia in un discorso in un villaggio sperduto della Serbia meridionale. È l’esatto contrario di ciò che si sente in Europa in questo momento… Quindi la domanda sulla bocca di tutti è: come può evolvere questo movimento? Credo che nessuno lo sappia. Vučić scommette su un esaurimento, ma finora non è stato così.
Quali sono le reazioni all’estero?
I partner occidentali della Serbia sono inquieti. Lo dimostra l’assordante silenzio dell’Unione Europea sull’argomento. Sebbene la Serbia sia candidata all’adesione all’UE e la lotta alla corruzione faccia parte di quanto normalmente richiesto ai Paesi candidati, diversi leader europei hanno preferito esprimere il loro sostegno a Vučić.
Le ragioni sono molteplici. La Germania sta cercando di sfruttare il litio della Serbia (sappiamo che il Paese europeo con più litio è probabilmente la Germania. Ma poiché la sua estrazione è estremamente inquinante, si preferisce sfruttarlo altrove, come in Ucraina o in Serbia, anche se i giacimenti sono molto più piccoli). Per questo il Cancelliere Scholz si è recentemente recato in Serbia con i rappresentanti dei padroni dell’industria automobilistica tedesca per negoziare un accordo sulle risorse minerarie strategiche; il garante di questo accordo è Vučić. Anche la Francia è interessata al litio, ma oltre a questo ha appena venduto dodici aerei Rafale alla Serbia, per la bagatella di 3 miliardi di euro. Non si sa come la Serbia pagherà il conto né a cosa serviranno gli aerei, visto che si tratta di un Paese neutrale e senza nemici, ma per un po’ ha comprato la benevolenza della Francia. L’8 febbraio Macron ha telefonato a Vučić per dirgli in sostanza che la Francia lo appoggiava.

A parte i casi tedesco e francese, le ragioni principali di questo silenzio europeo sono due. La prima è una falsa visione strategica – e qui entrano in gioco tutte le ambiguità e le bugie dell’idea di “Europa potenza”: se Vučić fa qualche promessa di fedeltà geopolitica, si pensa che sarà dalla nostra parte. Nel caso della Serbia, ciò è tanto più assurdo se si considera che la Serbia continua ad avere rapporti con la Russia ed è l’unico Paese candidato all’UE a non applicare le sanzioni. Invece di dire alla Serbia che deve allinearsi sulle politiche europee, la si corteggia nel tentativo di staccarla da Mosca. Questa visione geopolitica fa sì che l’UE rinunci a difendere lo Stato di diritto, che è il cuore dell’identità europea, perdendo così ancora più credibilità. Ed infine, la paura del vuoto: preferiamo un bastardo che conosciamo e che sappiamo come controllare ad un salto nel buio. Si pensa di conoscere i limiti da non superare, di poter negoziare, il che non è vero, perché possiamo vedere molto chiaramente come Vučić eccelle nel giocare sulle contraddizioni degli uni e degli altri. Ha detto agli europei: state attenti, se voi mi criticate mi avvicinerò ancora di più a Putin. Ma così facendo, l’Europa sta perdendo quel poco di credibilità che le era rimasta.
Dei media come Le Monde presentano il movimento come difensore del modello europeo. C’è un fondo di verità in questo discorso?
Se i media occidentali parlano poco di questo movimento, è perché hanno difficoltà ad inserirlo nelle caselle del bene e del male – hanno parlato molto di più del movimento in Georgia, per il quale la narrazione era semplice. Il movimento serbo è più complicato da capire, quindi la cosa più semplice è non parlarne. Ed i valori che dovrebbero essere al centro dell’identità europea – stato di diritto, uguaglianza, responsabilità dei politici eletti – non fanno parte del discorso dell’UE. Sono gli studenti serbi che li difendono in piazza, forse… Ma non si aspettano più nulla dall’UE. Non ci sono bandiere europee nelle manifestazioni, perché sanno che la Commissione appoggia questo regime predatore della democrazia.
Non ci sono rivendicazioni di altro genere, economiche in particolare?
Oltre al movimento studentesco, i cittadini si stanno mobilitando su varie altre lotte. Da diversi anni ci sono enormi mobilitazioni contro lo sfruttamento del litio da parte di Rio Tinto nella Serbia occidentale, guidate soprattutto dagli agricoltori della regione. Ci sono state anche altre manifestazioni ambientaliste, in particolare in difesa dell’acqua.
È importante capire la situazione nei Balcani: la transizione neoliberale che la Serbia ha conosciuto dopo la caduta di Milosevic negli anni Duemila ha portato a una deindustrializzazione su larga scala del Paese, e oggi stiamo assistendo a una pseudo-reindustrializzazione con l’arrivo di aziende di manodopera al servizio di grandi gruppi internazionali, che beneficiano di aiuti pubblici che a volte superano la massa salariale, ma dove le condizioni di lavoro sono così cattive che non riescono nemmeno a trattenere chi ci lavora. Dunque la popolazione balcanica emigra massicciamente, verso la Germania, che ha un enorme bisogno di manodopera in tutti i settori, ma anche verso l’Austria, i Paesi scandinavi, il Canada… Quindi, in realtà, i Balcani sono prima di tutto fornitori di manodopera, sia che lavorino sul posto che all’estero.
Allo stesso tempo, vengono sfruttati come riserva di risorse naturali: litio, rame, ma anche acqua, perché i Balcani sono un vero e proprio serbatoio. Negli ultimi anni sono state costruite diverse microdighe per la produzione di energia elettrica, con finanziamenti europei ed in nome della transizione verde, ma in realtà si trattava di riciclare denaro sporco, con una produzione energetica praticamente nulla. D’altra parte, in Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Macedonia, questi progetti hanno incontrato ovunque una forte resistenza da parte dei cittadini, che hanno detto: ci hanno tolto la dignità chiudendo le nostre imprese, e ora vogliono toglierci l’aria che respiriamo e l’acqua che beviamo. È una lotta vitale per le ultime risorse comuni.
Le mobilitazioni ambientaliste sono quindi molto forti e convergono con quelle studentesche, anche se queste ultime si attengono a una rivendicazione molto semplice con lo scopo di rappresentare tutte le persone mobilitate. E poi negli scioperi che si stanno diffondendo ci sono anche richieste categoriali. Direi che la formulazione di un discorso comune per tutte queste richieste non è ancora stata raggiunta, ma sono tutte presenti, coesistono.
Ed il settore agricolo?
Un tempo era molto importante, ma ora sta subendo una massiccia deregolamentazione. Nell’ambito del processo (teorico e molto illusorio) di avvicinamento all’UE, il mercato serbo è stato completamente aperto alle importazioni, in particolare ai prodotti agro-alimentari provenienti dall’UE, anche se il contrario non si verifica. Di conseguenza, nei supermercati è possibile trovare burro tedesco o verdure olandesi meno cari della produzione locale. Si tratta di una concorrenza assolutamente sleale e in realtà falsata.
L’inflazione gioca un ruolo in questa mobilitazione di massa?
L’inflazione è sempre stata elevata, ma tende a diminuire, come in tutta Europa. Da parecchie settimane, vari Paesi balcanici conoscono un interessante movimento di boicottaggio dei supermercati. Partito dalla Croazia (membro dell’UE dal 2013, ma non molto diversa dalla Serbia in termini socio-economici, anche se in Croazia c’è pure lo specchietto per le allodole del turismo, che rende le cose ancora più complicate, dato che fà salire i prezzi ma non i salari), si è esteso alla Slovenia, alla Serbia, alla Macedonia, al Montenegro e infine alla Serbia. Anche in questo caso, vediamo l’espressione di un malessere multiforme, per il momento senza riunificazione di tutte queste rivedicazioni. Ma questa collera sta inevitabilmente convergendo.
Questi movimenti sono anche loro ispirati dagli studenti?
 Sì e no. Nel caso dei consumatori che protestano contro l’inflazione, no. Ma abbiamo assistito a cose sorprendenti. In Croazia, ad esempio, ci sono stati enormi cortei di studenti a sostegno dei loro colleghi serbi, con – come simbolo forte – striscioni scritti in caratteri cirillici (3).
Sì e no. Nel caso dei consumatori che protestano contro l’inflazione, no. Ma abbiamo assistito a cose sorprendenti. In Croazia, ad esempio, ci sono stati enormi cortei di studenti a sostegno dei loro colleghi serbi, con – come simbolo forte – striscioni scritti in caratteri cirillici (3).
Il che dimostra che i movimenti sociali sono in grado di superare il nazionalismo.
Assolutamente sì. La prova viene data nelle piazze. Anche in Slovenia (membro dell’UE dal 2004), dopo che il sindaco di Lubiana ha dato un sostegno scioccante al regime serbo, ci sono state enormi manifestazioni a Lubiana e Maribor, con striscioni in cirillico che proclamavano “Un solo mondo, una sola lotta”. Si tratta di questioni molto profonde. Ma ci sono anche motivi di rabbia e mobilitazione specifici per alcuni Paesi. In Bosnia-Erzegovina, movimenti simili si stanno sviluppando in seguito alle disastrose inondazioni e frane dello scorso novembre, che hanno rivelato l’incompetenza dei responsabili politici. In Montenegro, la causa scatenante è stata la strage del 1° gennaio a Cetinje, un evento che ha rivelato un profondo malessere sociale ma anche il degrado dei servizi pubblici, con l’assenza di polizia in quel momento in tutta la città. È una rabbia che si sta diffondendo in tutti i Balcani, con un’esigenza comune di giustizia e di assunzione di responsabilità da parte dei politici. Resta da vedere fino a che punto questi movimenti possano convergere e svilupparsi.
Come si spiega che siano i Balcani ad insorgere attualmente, mentre nel resto dell’Europa c’è una calma piatta?
Non esiste una risposta semplice e definitiva. Quando i movimenti sociali esplodono, c’è sempre un elemento di casualità. Il disastro di Novi Sad è stata l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso della rabbia accumulata. Ma c’è una dimensione esistenziale in questo movimento, in cui le persone sono messe con le spalle al muro e non hanno altra scelta se non quella di ribellarsi. Uno degli slogan utilizzati in tutte le manifestazioni è “Rivoluzione o esilio”: o vinciamo o ce ne andiamo tutti. E non è una promessa a vanvera, perché se questo movimento fallisce, possiamo davvero aspettarci che un’intera generazione lasci la Serbia per rifarsi una vita altrove. In secondo luogo, che cosa rende possibile questo movimento e perché sta avendo una risonanza così rapida nella società? Forse perché nei Balcani la società è un po’ meno atomizzata e più solidale che in altri Paesi europei. Ma c’è anche, va riconosciuto, una grande intelligenza degli studenti. Percorrere a piedi tutto il Paese per rompere il silenzio dei media e far sentire la propria voce in ogni villaggio e città del Paese ha anche l’effetto di rompere l’irrealtà dei social network. Non è la stessa cosa mettere “mi piace” a un post su una manifestazione studentesca, e preparare da mangiare per questi studenti che arrivano da voi la sera, ospitarli e prendersi cura di loro. Questo dà alle cose una nuova realtà.
Le enormi manifestazioni in Grecia di commemorazione della catastrofe ferroviaria di Tempé, è una semplice coincidenza?
Questa è l’eco. Naturalmente, l’incidente di Tempé è anche una storia di corruzione e di tagli ai servizi pubblici. Ma le grandi manifestazioni di due anni fa, quando è accaduto, erano rifluite, ed ora è il vedere quel che sta accadendo in Serbia che ha ridato energia ai greci. Quindi c’è una sorta di emulazione che ha certamente giocato un ruolo. A Belgrado sono andati a manifestare davanti all’ambasciata greca. Quindi, sì, c’è una sorta di risonanza, di solidarietà che si sta riproducendo da un Paese all’altro della regione.
E la diaspora serba?
La diaspora serba è fortemente mobilitata. Ha manifestato in tutta l’Europa, negli Stati Uniti, in Canada, a Tunisi… (4)
Quale reazione ci si può aspettare da parte del potere ?
Vučić ha giocato all’inizio la carta della repressione, poi ha smesso quando ha visto che era controproducente. Poi ha fatto saltare un fusibile con le dimissioni del primo ministro (ma di fatto tutti i poteri sono concentrati nelle mani del presidente), e questo non ha cambiato nulla.
Esclusa l’ipotesi di elezioni anticipate, ci si aspetta ora un cambio di governo con la stessa maggioranza parlamentare, il che non cambierà nulla. Nessuna iniziativa del regime sta funzionando, l’unica carta che gli resta è quella dell’esaurimento. Se alla fine ciò dovesse accadere, la repressione potrebbe tornare. Ma per il momento non ci siamo.
Può contare sulla fedeltà delle forze dell’ordine?
In una certa misura, sì. Ma è evidente che molti agenti di polizia si sentono solidali con questo movimento, perché tutti hanno un parente o un giovane vicino di casa che è studente. Poi ci sono gli scagnozzi del regime, le unità speciali di polizia, i servizi segreti. Lì si combattono battaglie numeriche piuttosto complesse, perché non credo che Vučić abbia il controllo completo dello Stato profondo. Questo è l’incognita dell’equazione di ciò che sta accadendo oggi.
Ed i sindacati?
Il problema è che non sono molto forti. Nelle aziende di manodopera che hanno sostituito le grandi imprese quasi scomparse, nessun sindacato riesce ad affermarsi. Nelle aziende comprate dai cinesi, come le acciaierie Smederevo, è quasi impossibile creare un sindacato indipendente.
Accanto al sindacato ufficiale, che ancora sopravvive, esistono sindacati più combattivi, ma questi sono molto poco radicati nel settore privato. Sono nel settore pubblico. Ma gli insegnanti sono già in sciopero, la sanità potrebbe mobilitarsi. Ci sono stati anche dei piccoli movimenti, con qualche ora di sciopero all’aeroporto di Belgrado. Anche gli operatori culturali sono molto mobilitati, ma non sono loro che possono bloccare un Paese…
Ma non è che la debolezza dei sindacati ha favorito il consolidamento del movimento, dato che erano incapaci di controllarlo?
È vero che i sindacati in Serbia non sarebbero in grado di negoziare la fine di un movimento. Ma questo movimento è portato avanti in primo luogo dagli studenti, con i bastioni che sono le facoltà occupate, di cui hanno il controllo. Sono anche questi punti di ancoraggio materiali che permettono al movimento di reggere. Ci sarebbe una repressione violenta, ad esempio, se la polizia tentasse di entrare in una facoltà, cosa che non è possibile se non in una logica di estremo inasprimento del regime.
Che cosa si potrebbe fare per aiutare l’estensione del movimento al di là dei Balcani?
Credo che il futuro del movimento dipenda innanzitutto dalla sua estensione ad altre categorie sociali in Serbia. Anche l’estensione oltre i confini è molto importante, e quello che si può fare è parlare di questo movimento, cercare di rompere il silenzio mediatico che lo circonda.
NOTE
1) www.courrierdesbalkans.fr – Dérens ha inoltre appena pubblicato Les Balkans en cent questions – Carrefour sous influence, con le edizioni Taillandier.
2) Su Fréquence Paris Plurielle (106.3 MHz o rfpp.net). Si può riascoltare la trasmissione alla pagina: vivelasociale.org/les-emissions-recentes
3) In Serbia ed in Croazia, si parla in realtà una stessa lingua, il serbo-croato, con delle varianti. Ma si scrive in caratteri cirillici in Serbia, latini in Croazia.
4) A Parigi, si manifesta tutte le settimane davanti all’ambasciata Serba. Per delle informazioni precise si può consultare il sito del Courrier des Balkans.
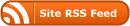
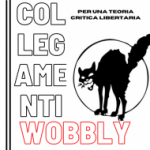
Commenti recenti